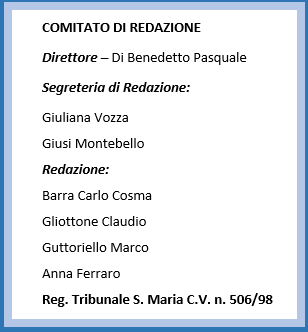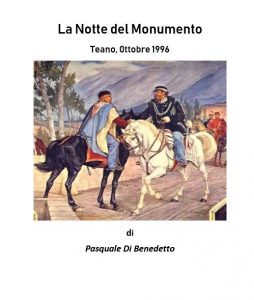La nostra educazione al limite, alla finitezza, rende impossibile un’apertura incondizionata alla percezione del reale. Eppure i confini del nostro sguardo sul mondo, non sono i confini del mondo, nonostante la provocazione di Wittgenstein che descrive i limiti del mio linguaggio come i limiti del mio mondo. Significa che la nostra comprensione e esperienza del mondo sono limitate dalla nostra capacità di esprimerlo attraverso il linguaggio. Che il senso comune sia un dogma è solo il senso comune a non saperlo. Ciò che non possiamo dire , in quanto senso comune ,non possiamo nemmeno pensare o comprendere pienamente. Se il nostro linguaggio è limitato lo è anche la nostra comprensione del mondo. Quando non abbiamo a disposizione una parola per esprimere un concetto non possiamo nemmeno formularlo. L’uso della filosofia non è filosofia, per spostarci davvero dal senso comune non possiamo evitare il discorso intorno al tutto, all’intero, per quanto faccia problema anche la sua stessa semantizzazione: il linguaggio che dovrebbe dirlo è anch’esso finito ,il relativista ha vita facile a spostare i significati . Se dico che A non è A, leggo subito la contraddizione del mio dire ,ma se dico che tutto è relativo , non avverto più lo stesso disagio per la mancata identità tra i due termini di relazione. Se ci allontaniamo dall’intero, dal significato complesso, dall’apofansi, siamo nella sintassi non nella filosofia. La differenza ontologica, nella filosofia severiniana, è tra l’intero dell’essere immutabile e l’essere che appare processualmente, diacronicamente, nel tempo, in ciò che il senso comune chiama esperienza. La sua teoresi è più larga del linguaggio che può dirla, apre all’infinito ,mentre il linguaggio è uno strumento finito. Al linguaggio è preclusa strutturalmente la possibilità di dire l’intero ,il tutto. Lo stesso dialogo che il senso comune considera massimo strumento della comunicazione umana , con tutta l’aura che il moralista gli attribuisce ,mostra tutta la sua insufficienza ontologica nell’ambito filosofico, non è mai bastato a fermare le guerre né a realizzare la pace. Il linguaggio in realtà è esso stesso già violenza , non coincide con la cosa che dice ,è solo il tentativo di rappresentarla . Il dialogo fuor di retorica , resta il tentativo di affermare una volontà, quindi un che di infondato, una struttura dinamica che non può essere determinata : la volontà vuole volere, il suo è un cattivo infinito, non può conoscere limite alcuno, questo ne inficerebbe l’essenza; una volontà che non vuole , non è volontà. La metafisica non è quel mondo trascendentale che sta al di là della nostra presunta finitezza, lo spiega bene Massimo Cacciari nel suo ultimo libro “ La metafisica concreta”. Sotto attacco è il riduzionismo scientifico, per cui ciò che non vediamo non ha alcuna valenza ontologica, non esiste. Una filiazione della filosofia heideggeriana, per cui la differenza ontologica è tra essere e ente, ci sarà un taglio netto tra essenza e esistenza. Nessuno farà più caso che ciò che viene dedotto già non è vera metafisica, manca di originalità, non essendo fondato non può fondare alcunche’. L’intero filosofico, il tutto, è il significato complesso, il molteplice , che pur è chiamato in causa ogni volta che vogliamo affermare una certa determinatezza , che per essere tale , cioè identica a se stessa, deve far apparire l’intero campo semantico a cui è relata di necessità. Se io nomino il bicchiere, riesco a tenerlo fermo nel suo significato, perché appare che il bicchiere non è il tavolo, né un sospiro, né il computer che sto usando per scrivere. QUESTO è L’INTERO FILOSIFICO, questo è ciò che rende il bicchiere un oggetto complesso per la filosofia, e semplice per la scienza, che ha smesso di essere episteme, quindi di essere verità, rinunciando a quel tutto di cui è parte. Per la teoresi severiniana l’essere è struttura originaria, unione tra astratto e concreto e non può essere staccata dal suo apparire. Tutti noi avvertiamo una sorta di eccedenza ontologica del nostro essere, sentiamo che c’è un oltre, un’iperbole che ci sfugge , ma non abbastanza da non averne contezza alcuna. Resta sullo sfondo di una coscienza che ancora non sa se è il contenuto o il contenente della realtà. Di fatto crediamo tutti nella scienza , proprio come prima credevamo in Dio, nonostante l’ipoteticità delle sue certezze. Noi usiamo l’espressione “ Sii scientifico “ ,la cui logica sottesa vorrebbe vantare una verità assoluta, la stessa che il positivismo scientifico ha rinnegato in nome del progresso, che l’intero 900 ha inseguito con la stessa venerazione , se non idolatria, attribuite alle fedi religiose come espressioni di comunità minoritarie , non emancipate. Oggi l’uomo ha smesso di interrogarsi è fondamentalmente desiderio di vita e timore di morte. Ogni fede sul suo sfondo è malafede, paradossalmente per il pensiero vero, è già violenza, attribuisce un certo contenuto arbitrariamente , perché argomento di cose non apparenti. Gli argomenti della fede, per quanto solidi, mancano di evidenza. E’ gioco-forza spostare l’attenzione dal creatore alla creatura, perché l’uomo potesse essere grande , Dio doveva diventare piccolo. Il relativismo nega che la ragione possa conoscere qualcosa di incontrovertibile, verità assolute, però lo fa rivendicando lo stesso atteggiamento fideistico, a difesa del capitalismo , fino a farci metabolizzare la sua inemendabilità. L’assoluto che abbiamo rinnegano tanto quanto divino che come verità è stato poi sussunto in actu signato, a supporto del mercato e dei suoi capitali. L’ente è stato liberato dall’essere per poterlo manipolare, la religione lo aveva fatto restituendoci il bene tolto con un disegno escatologico di salvezza , per quanto rinviato a nuova vita, la scienza lo fa senza orizzonti di salvezza, spacciandosi per verità , ma è solo persuasione condivisa che lo sia. L’uomo moderno è un fedele più di quello del medioevo, è solo l’oggetto di culto a cambiare. La stessa storia è vista come una religione laica, come luogo che crea da se le cose del mondo. L’espressione “ e’ la storia stessa a superarlo” , attribuisce alla storia uno spirito in corpo che un inesistenziale non può avere. La metafisica è stata considerata arbitraria, poco spendibile perché poco verificabile, ma tutte le sue categorie sono chiamate continuamente a giustificare la mancata razionalità di un reale che in quanto tale è prodotto dallo spirito del tempo ma non riesce a tenersi conforme ai concetti che dovrebbero sorreggerlo. E’ l’io puro a poter scrivere la storia e non viceversa, è solo l’uomo a poter pensare a ciò che ancora non c’è, è l’uomo che abitando un certo spazio lo fa esistere, il mondo come la storia sono degli inesistenziali .Questo sarà il 900 prodotto da Martin Heidegger. Per Severino la storia è un processo diacronico ,dettato dalla necessità dell’essere e non dalla volontà umana , che crede soltanto di poter volere. Davanti alla morte la volontà mostra tutta la sua mancanza di verità, svuotandosi di ogni significato, cos’è la morte se non l’implosione di ogni volontà . Il nichilismo del nostro tempo è proprio ciò che intende negare la necessità dell’essere. Per poterlo fare deve dire che è, deve apparire , riconfermando l’essere suo malgrado. La necessità dell’essere è la condizione per cui tutto ciò che si pone , riesce a porsi, tentare di negarla induce in un’autonegazione non prevista dal pensiero che pensa con una logica nichilista: tutto ciò che appare nell’esperienza ha una base ontologica nell’essere che non può essere negata ,perché la verità è incontrovertibile quando si pone da se senza bisogno di alcun testimone .La volontà di potenza che pure siamo, nel suo tentativo di trasformare il mondo, lo patisce , cos’è il dolore se non il doversi arrendere a una volontà che non è la nostra. La dove appare qualcosa appare l’essere, non la nostra volontà , quell’intero , quel tutto che ci è precluso, pur essendone parte. E’ questo il gap cognitivo di cui si serve il relativismo per poter affermare che tutto è relativo ,spogliando un’identità da sé stessa , a favore di una gnoseologia che semplifichi la complessità del significato , fino a separarlo dalla sua verità, fino a identificare i diversi. La verità non è una questione come un’altra, è la questione. L’imprescindibile a cui nessun dire che voglia avere valore, può rinunciare. Questo è il senso della filosofia, lo stesso Socrate è uno dei più alti paradigmi tra le figure cristologiche proprio perché parresiasta per antonomasia. Tutti sappiamo com’è finita la sua evasione dall’antro platonico, ma il parresiasta non ha mai avuto vita facile, anche se i semi gettati delle sue verità continueranno per sempre a dare i loro frutti. Io stessa in questa piccola rubrica filosofica tento con tutte le enegie possibili di educare me stessa e chi mi legge alla bellezza della verità , che fuor di retorica è l’unica morale possibile in un reale che ascrive la stessa dignità umana in un relativismo gnoseologico ,volto alla rinuncia dei veri significati dei concetti complessi.Emanuele Severino educa alla verità autentica dell’essere, offre una via d’uscita dall’angoscia delle aporie del nostro tempo, invitando a superare la notte del nichilismo, per riscoprire la luce della verità dell’essere, che non conosce divenire , è sempre e soltanto identità originaria. Il mio tentativo è quello di non farvi rinunciare alla complessità ,le semplificazioni sono pericolose ,servono a togliere verità, questa è la vera violenza dei tempi moderni. L’intero del significato, richiede un certo sforzo intellettuale, ma cogliere la verità dell’essere sposta l’uomo dalle categorie utilitaristiche , che governano il mondo, a quelle a cui si può aspirare solo con quell’intelligere a cui si accede per gradi, proprio grazie al nostro spingere , al nostro chiedere sempre di più a noi stessi. Le critiche sono necessarie, aiutano la nostra crescita intellettuale, sono uno strumento emancipativo, ma inviterei a stare sull’argomento , evitando la fallacia ad hominem : io non sono il mio argomento.
La nostra educazione al limite, alla finitezza, rende impossibile un’apertura incondizionata alla percezione del reale. Eppure i confini del nostro sguardo sul mondo, non sono i confini del mondo, nonostante la provocazione di Wittgenstein che descrive i limiti del mio linguaggio come i limiti del mio mondo. Significa che la nostra comprensione e esperienza del mondo sono limitate dalla nostra capacità di esprimerlo attraverso il linguaggio. Che il senso comune sia un dogma è solo il senso comune a non saperlo. Ciò che non possiamo dire , in quanto senso comune ,non possiamo nemmeno pensare o comprendere pienamente. Se il nostro linguaggio è limitato lo è anche la nostra comprensione del mondo. Quando non abbiamo a disposizione una parola per esprimere un concetto non possiamo nemmeno formularlo. L’uso della filosofia non è filosofia, per spostarci davvero dal senso comune non possiamo evitare il discorso intorno al tutto, all’intero, per quanto faccia problema anche la sua stessa semantizzazione: il linguaggio che dovrebbe dirlo è anch’esso finito ,il relativista ha vita facile a spostare i significati . Se dico che A non è A, leggo subito la contraddizione del mio dire ,ma se dico che tutto è relativo , non avverto più lo stesso disagio per la mancata identità tra i due termini di relazione. Se ci allontaniamo dall’intero, dal significato complesso, dall’apofansi, siamo nella sintassi non nella filosofia. La differenza ontologica, nella filosofia severiniana, è tra l’intero dell’essere immutabile e l’essere che appare processualmente, diacronicamente, nel tempo, in ciò che il senso comune chiama esperienza. La sua teoresi è più larga del linguaggio che può dirla, apre all’infinito ,mentre il linguaggio è uno strumento finito. Al linguaggio è preclusa strutturalmente la possibilità di dire l’intero ,il tutto. Lo stesso dialogo che il senso comune considera massimo strumento della comunicazione umana , con tutta l’aura che il moralista gli attribuisce ,mostra tutta la sua insufficienza ontologica nell’ambito filosofico, non è mai bastato a fermare le guerre né a realizzare la pace. Il linguaggio in realtà è esso stesso già violenza , non coincide con la cosa che dice ,è solo il tentativo di rappresentarla . Il dialogo fuor di retorica , resta il tentativo di affermare una volontà, quindi un che di infondato, una struttura dinamica che non può essere determinata : la volontà vuole volere, il suo è un cattivo infinito, non può conoscere limite alcuno, questo ne inficerebbe l’essenza; una volontà che non vuole , non è volontà. La metafisica non è quel mondo trascendentale che sta al di là della nostra presunta finitezza, lo spiega bene Massimo Cacciari nel suo ultimo libro “ La metafisica concreta”. Sotto attacco è il riduzionismo scientifico, per cui ciò che non vediamo non ha alcuna valenza ontologica, non esiste. Una filiazione della filosofia heideggeriana, per cui la differenza ontologica è tra essere e ente, ci sarà un taglio netto tra essenza e esistenza. Nessuno farà più caso che ciò che viene dedotto già non è vera metafisica, manca di originalità, non essendo fondato non può fondare alcunche’. L’intero filosofico, il tutto, è il significato complesso, il molteplice , che pur è chiamato in causa ogni volta che vogliamo affermare una certa determinatezza , che per essere tale , cioè identica a se stessa, deve far apparire l’intero campo semantico a cui è relata di necessità. Se io nomino il bicchiere, riesco a tenerlo fermo nel suo significato, perché appare che il bicchiere non è il tavolo, né un sospiro, né il computer che sto usando per scrivere. QUESTO è L’INTERO FILOSIFICO, questo è ciò che rende il bicchiere un oggetto complesso per la filosofia, e semplice per la scienza, che ha smesso di essere episteme, quindi di essere verità, rinunciando a quel tutto di cui è parte. Per la teoresi severiniana l’essere è struttura originaria, unione tra astratto e concreto e non può essere staccata dal suo apparire. Tutti noi avvertiamo una sorta di eccedenza ontologica del nostro essere, sentiamo che c’è un oltre, un’iperbole che ci sfugge , ma non abbastanza da non averne contezza alcuna. Resta sullo sfondo di una coscienza che ancora non sa se è il contenuto o il contenente della realtà. Di fatto crediamo tutti nella scienza , proprio come prima credevamo in Dio, nonostante l’ipoteticità delle sue certezze. Noi usiamo l’espressione “ Sii scientifico “ ,la cui logica sottesa vorrebbe vantare una verità assoluta, la stessa che il positivismo scientifico ha rinnegato in nome del progresso, che l’intero 900 ha inseguito con la stessa venerazione , se non idolatria, attribuite alle fedi religiose come espressioni di comunità minoritarie , non emancipate. Oggi l’uomo ha smesso di interrogarsi è fondamentalmente desiderio di vita e timore di morte. Ogni fede sul suo sfondo è malafede, paradossalmente per il pensiero vero, è già violenza, attribuisce un certo contenuto arbitrariamente , perché argomento di cose non apparenti. Gli argomenti della fede, per quanto solidi, mancano di evidenza. E’ gioco-forza spostare l’attenzione dal creatore alla creatura, perché l’uomo potesse essere grande , Dio doveva diventare piccolo. Il relativismo nega che la ragione possa conoscere qualcosa di incontrovertibile, verità assolute, però lo fa rivendicando lo stesso atteggiamento fideistico, a difesa del capitalismo , fino a farci metabolizzare la sua inemendabilità. L’assoluto che abbiamo rinnegano tanto quanto divino che come verità è stato poi sussunto in actu signato, a supporto del mercato e dei suoi capitali. L’ente è stato liberato dall’essere per poterlo manipolare, la religione lo aveva fatto restituendoci il bene tolto con un disegno escatologico di salvezza , per quanto rinviato a nuova vita, la scienza lo fa senza orizzonti di salvezza, spacciandosi per verità , ma è solo persuasione condivisa che lo sia. L’uomo moderno è un fedele più di quello del medioevo, è solo l’oggetto di culto a cambiare. La stessa storia è vista come una religione laica, come luogo che crea da se le cose del mondo. L’espressione “ e’ la storia stessa a superarlo” , attribuisce alla storia uno spirito in corpo che un inesistenziale non può avere. La metafisica è stata considerata arbitraria, poco spendibile perché poco verificabile, ma tutte le sue categorie sono chiamate continuamente a giustificare la mancata razionalità di un reale che in quanto tale è prodotto dallo spirito del tempo ma non riesce a tenersi conforme ai concetti che dovrebbero sorreggerlo. E’ l’io puro a poter scrivere la storia e non viceversa, è solo l’uomo a poter pensare a ciò che ancora non c’è, è l’uomo che abitando un certo spazio lo fa esistere, il mondo come la storia sono degli inesistenziali .Questo sarà il 900 prodotto da Martin Heidegger. Per Severino la storia è un processo diacronico ,dettato dalla necessità dell’essere e non dalla volontà umana , che crede soltanto di poter volere. Davanti alla morte la volontà mostra tutta la sua mancanza di verità, svuotandosi di ogni significato, cos’è la morte se non l’implosione di ogni volontà . Il nichilismo del nostro tempo è proprio ciò che intende negare la necessità dell’essere. Per poterlo fare deve dire che è, deve apparire , riconfermando l’essere suo malgrado. La necessità dell’essere è la condizione per cui tutto ciò che si pone , riesce a porsi, tentare di negarla induce in un’autonegazione non prevista dal pensiero che pensa con una logica nichilista: tutto ciò che appare nell’esperienza ha una base ontologica nell’essere che non può essere negata ,perché la verità è incontrovertibile quando si pone da se senza bisogno di alcun testimone .La volontà di potenza che pure siamo, nel suo tentativo di trasformare il mondo, lo patisce , cos’è il dolore se non il doversi arrendere a una volontà che non è la nostra. La dove appare qualcosa appare l’essere, non la nostra volontà , quell’intero , quel tutto che ci è precluso, pur essendone parte. E’ questo il gap cognitivo di cui si serve il relativismo per poter affermare che tutto è relativo ,spogliando un’identità da sé stessa , a favore di una gnoseologia che semplifichi la complessità del significato , fino a separarlo dalla sua verità, fino a identificare i diversi. La verità non è una questione come un’altra, è la questione. L’imprescindibile a cui nessun dire che voglia avere valore, può rinunciare. Questo è il senso della filosofia, lo stesso Socrate è uno dei più alti paradigmi tra le figure cristologiche proprio perché parresiasta per antonomasia. Tutti sappiamo com’è finita la sua evasione dall’antro platonico, ma il parresiasta non ha mai avuto vita facile, anche se i semi gettati delle sue verità continueranno per sempre a dare i loro frutti. Io stessa in questa piccola rubrica filosofica tento con tutte le enegie possibili di educare me stessa e chi mi legge alla bellezza della verità , che fuor di retorica è l’unica morale possibile in un reale che ascrive la stessa dignità umana in un relativismo gnoseologico ,volto alla rinuncia dei veri significati dei concetti complessi.Emanuele Severino educa alla verità autentica dell’essere, offre una via d’uscita dall’angoscia delle aporie del nostro tempo, invitando a superare la notte del nichilismo, per riscoprire la luce della verità dell’essere, che non conosce divenire , è sempre e soltanto identità originaria. Il mio tentativo è quello di non farvi rinunciare alla complessità ,le semplificazioni sono pericolose ,servono a togliere verità, questa è la vera violenza dei tempi moderni. L’intero del significato, richiede un certo sforzo intellettuale, ma cogliere la verità dell’essere sposta l’uomo dalle categorie utilitaristiche , che governano il mondo, a quelle a cui si può aspirare solo con quell’intelligere a cui si accede per gradi, proprio grazie al nostro spingere , al nostro chiedere sempre di più a noi stessi. Le critiche sono necessarie, aiutano la nostra crescita intellettuale, sono uno strumento emancipativo, ma inviterei a stare sull’argomento , evitando la fallacia ad hominem : io non sono il mio argomento.
Augurandovi buone vacanze , vi lascio al canto di un giullare, Eugenio Bennato, un menestrello dall’anima popolare , che dileggia il potere, nel tentativo di restituire dignità a un grande parresiasta ,che “ murett accis pecchè non ce vulett sta”, spostando l’impossibile al con-fine del realizzabile; questa è la vera filosofia, quella che si fa vita ,magari nelle gesta di un rivoluzionario. Quella di Ninco Nanco è una storia come tante , ma il suo canto arriva da un seme di desiderio di giustizia ,affidato al vento tanto tempo fa , che diventerà un tempesta nelle parole di un cantastorie del nostro tempo che ne condividerà tutto l’orgoglio meridionale.
A voi il link: https://www.youtube.com/watch?v=t4Nq_1jKlX0
ANNA FERRARO

 OFFICINA DI FILOSOFIA
OFFICINA DI FILOSOFIA  INCONTRO FORMATIVO SU COMUNICAZIONE EMOZIONALE E DISTURBI ALIMENTARI ALL’I.C. “VINCENZO LAURENZA” DI TEANO.
INCONTRO FORMATIVO SU COMUNICAZIONE EMOZIONALE E DISTURBI ALIMENTARI ALL’I.C. “VINCENZO LAURENZA” DI TEANO.  CONTINUA IL DRAMMA DEL NUOVO (VECCHIO) SCUOLABUS
CONTINUA IL DRAMMA DEL NUOVO (VECCHIO) SCUOLABUS  QUANDO L’ABITO…FA IL MONACO!!!
QUANDO L’ABITO…FA IL MONACO!!!