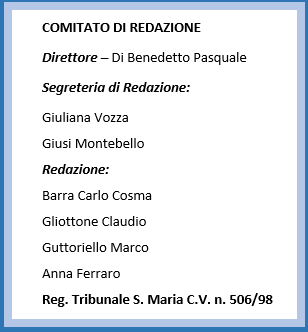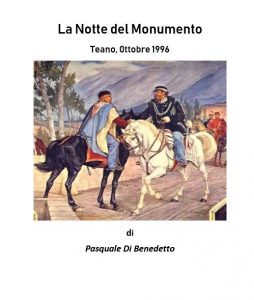Si potrebbe così parafrasare l’incipit della poesia “I pastori” nella quale Gabriele D’Annunzio descrive, con la sua musicale maestria, la “transumanza”, cioè lo spostamento stagionale, attuato dai pastori abruzzesi, delle mandrie dai pascoli montani verso il mare.
Invero il D’annunzio parla di “Settembre, andiamo, è tempo di migrare” perché la transumanza si svolge in quel mese, ed allora potremmo anche parafrasarla dicendo: “novembre, andiamo, è tempo di… votare”, perché la transumanza alla quale ci riferiamo non è quella delle mandrie verso il mare, ma dei politici verso altre sponde, diverse da quelle dove hanno pasteggiato fino a ieri.
È chiaro che mi riferisco alla pletora di sindaci e loro seguaci che, ad un passo dalle elezioni regionali campane, hanno abbandonato il pur nutriente pascolo “deluchiano” non appena si son resi conto che si andava sempre più rinsecchendo. Hanno così attuato un tempestivo, ma non troppo, salto politico approdando su una sponda politicamente fino a ieri a loro avversa e da loro dileggiata. Vi par cosa da niente? Del resto si è sempre detto che la prima “qualità” (?) di un politico debba essere quella di “annusare il vento che tira” per saperlo sfruttare di poppa e non di prua. Ma dovremmo prima stabilire cosa intendiamo oggi per “politico”; vediamo chi può aiutarci a definirlo.
“C’è da stupirsi davvero di come mai quanti desiderano suonare la cetra o il flauto o cavalcare o diventare capaci di qualcun’altra di queste cose, cerchino di praticare quanto più è possibile l’arte di cui vogliono diventare esperti, e non da soli, ma sotto la guida di coloro che hanno fama di essere i migliori… mentre tra quelli che desiderano diventare abili a parlare e agire nel campo della politica, alcuni abbiano la presunzione di diventarlo all’improvviso e spontaneamente, senza esercizio e senza impegno. E invece questa attività sembra più difficile da realizzarsi di quelle.”.
Sembra un brano tratto da un moderno editoriale di Feltri o di Sallusti, ma queste parole furono pronunciate nientepopodimeno che da Socrate, appena 2300 anni fa. Furono pronunciate, come tante altre, ma non scritte perché Socrate non ci ha lasciato scritto mai niente. Come Buddha o Gesù, il cui pensiero ci è stato riportato solo dai loro discepoli: ma Socrate sosteneva che la scrittura ha un grosso difetto: che se interrogata non può risponderci!
Un discorsetto semplice, quello di Socrate: ma che ci illumina sulla comprensione dei comportamenti di tanti “politici”, specie se di secondo piano, che probabilmente del significato di questo termine non abbiano capito una beata…mazza (consentitemi la espressione)!
Orbene la politica deriva il suo nome dalla “polis”, la “città stato” della antica Grecia che si governava con proprie leggi, un proprio governo ed una propria moneta (un poco come qualche governatore nostro corregionale avrebbe voluto fare oggi con la Campania intera). Il sistema “democratico” nacque proprio allora, specie ad Atene, dove tutti i maschi della città si riunivano nell’Assemblea per discutere ed approvare le leggi secondo principi di “isegoria”, libertà di parola, e di “isonomia”, uguaglianza di diritti di fronte alla legge. Tutto questo sul finire del sesto secolo avanti Cristo!
Vi renderete facilmente conto di come fosse impossibile per ogni cittadino propugnare una tesi che risultasse partorita per un vantaggio personale o di una piccola parte dei cittadini, come si usa fare oggi aggirando ogni problema. Le leggi venivano discusse e approvate da tutti gli abitanti.
Oggi sarebbe impossibile tornare a questo sistema, ma la capacità di un vero politico di oggi (merce sempre più rara) consiste proprio nel battersi non per un tornaconto personale o di parte, ma per il benessere di tutti gli amministrati o per la più gran parte di essi: come lo fece De Gasperi, capace di ribaltare, con un discorso leale e sentito, il giudizio negativissimo sul nostro paese di tutti i componenti della Conferenza della Pace di Parigi nel 1946, o Togliatti, quando si fece promotore dell’amnistia per i crimini di guerra, o di Segni, che sostenne a spada tratta la Legge Agraria, che pure lo avrebbe danneggiato personalmente.
Dall’epoca della polis greca è cambiato tutto. Oggi l’elettore non può partecipare all’assemblea decisiva allora vigente perché oggi esistono gli “stati” con milioni e milioni di esseri in più. Allora ci siamo inventati i “partiti” che raggruppano persone che condividono alcune linee ideologiche di base che dovrebbero dare all’elettore la sicurezza di come gli eletti da loro si comporteranno per soddisfare principalmente quelle idee di fronte ad ogni situazione possibile. Così se io sono economicamente liberista come Einaudi non appoggerò mai una legge statalista come proporrebbe Nenni: ed il mio elettore che, in base principalmente a queste idee, mi ha dato il suo sostegno non si sentirà personalmente tradito se io passo baracca e burattini nel partito socialista? Penserà che io abbia avuto una crisi di coscienza (a tal proposito andatevi a leggere la omonima poesia di Trilussa) o che possa essere stato indotto a farlo per altre motivazioni che riguardano principalmente la mia persona e non la parte che mi ha sostenuto. E andate a dargli torto!
Ultima riflessione ancora datata nel sesto secolo avanti Cristo: la possibilità che la democrazia degeneri in “oclocrazia” (oclos=moltitudine, massa) cioè predominio delle masse che fanno valere le loro istanze con agitazioni di piazza imponendosi sul potere legittimo e sulle leggi.
Pensate che Landini ne sia a conoscenza? Se sì ci sarebbe da preoccuparsi.
Claudio Gliottone


 “NOVEMBRE, ANDIAMO, È TEMPO DI MIGRARE…”
“NOVEMBRE, ANDIAMO, È TEMPO DI MIGRARE…” 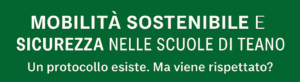 “NOVEMBRE, ANDIAMO, È TEMPO DI MIGRARE…”
“NOVEMBRE, ANDIAMO, È TEMPO DI MIGRARE…”  VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO
VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO  LA SCOPA NUOVA…
LA SCOPA NUOVA…  TEANO, LA CITTÀ DIMENTICATA: UN GRIDO CONTRO L’ABBANDONO.
TEANO, LA CITTÀ DIMENTICATA: UN GRIDO CONTRO L’ABBANDONO.