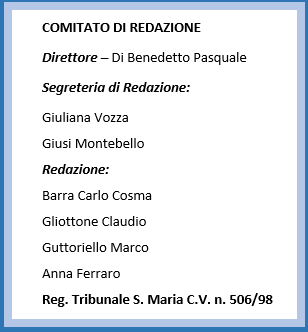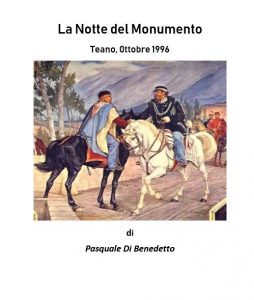…cantava, sul finire del quindicesimo secolo, Lorenzo il Magnifico, nella sua poesia “Canzona di Bacco e Arianna” e con essa, fatta l’amara considerazione “che si fugge tuttavia”, invitava tutti quelli che volessero esser “lieti” a farlo perché, concludeva amaramente, “del diman con v’è certezza”.
Quanta amara verità in quest’ultima rimeggiante frase rimasta perfettamente attuale in tutti i tempi ed oggi più valida che mai!
Fu pubblicata nel 1490 e rifletteva, ad un tempo, più stati d’animo di varia natura.
Si era all’inizio del Rinascimento, uno dei migliori evi storici dell’Italia e forse dell’Europa intera, e la poesia può esser letta con una nota di celato ottimismo: pur se non c’è certezza del futuro, pensiamo ad esser lieti a fronte degli anni bui del morente Medio Evo; un invito a riprendersi in mano la propria esistenza, fino ad allora delegata alla autorità papale od imperiale o repressa da assurdi misticismi imbevuti di malsane superstizioni.
“Chi vuol esser lieto, sia…” e cominciarono ad esserlo tutti quei grandi che diedero vita ad una prima “stagion più bella” (per dirla col Carducci) della nostra Italia, e che eccelsero in tutte la arti, dalla musica alla letteratura, dalla pittura alla scultura, alla architettura, creando opere ineguagliabili.
Era un invito a godere delle grandi cose, in primis quella di “esserci” e di “amare” come accade a Bacco ed Arianna, e delle piccole, come la natura, la bellezza, e i vari piaceri della vita terrena.
Tutto questo perché è vero che del “diman non v’è certezza” ma non ci si dimentichi mai di “quanto è bella giovinezza”.
Ma la “giovinezza” non è “la gioventù”, così come la “vecchiezza” non è la “vecchiaia”: un mero fatto anagrafico le seconde definizioni, ben altro le prime.
La “giovinezza” è la sensazione di un inizio, la certezza consapevole di un futuro da modellarsi addosso, la coscienza di dover far parte di un vivere sociale nel migliore dei modi, amando per essere amato, rispettando per essere rispettato; semplicemente è uno stato d’animo non puramente anagrafico, come la “gioventù”. Questa, invece, potremmo definirla, oggi più che mai, come l’unica sensazione anagrafica che ti consente di fare quello che vuoi, di picchiare e uccidere i tuoi amici, a volte i tuoi genitori, di giocare al tiro a segno col povero vecchio barbone immigrato sparandogli in fronte, di ammazzare figli appena partoriti e di sotterrarli nel giardino, di sfilare per strada sfasciando vetrine, macchine, lampioni stradali e di strappare persino la bandiera nazionale, animati sempre da uno stupido ribellismo contro tutto e contro tutti, ma essenzialmente solo a fine sé stesso. Certamente questo non è l’”esser lieto” al quale si riferiva Lorenzo il Magnifico.
Di contrapposto la “vecchiaia” reca nel termine l’idea di un disfacimento fisico e mentale, di un abbandono spesso non motivato di ogni legame col passato e di ogni aspettativa futura, in uno (siano contenti i lettori anglofili) stand-by più mentale che fisico, il quale si ripercuote sul secondo aggravandone ogni aspetto di socialità.
La “vecchiezza” è invece la sensazione della conclusione, è il momento di raccogliere punto per punto tutti i momenti di vita, i brutti e i belli, di passarli in rassegna traendone da ognuno insegnamento e morale, di farne un pacchetto e di trasmetterlo agli altri, coetanei o più giovani che siano. Ma il tutto non da spocchioso professore assillante, ma da persona ancor più inserita in un contesto sociale che aspetta e merita gli insegnamenti di una persona che non può non averne tanti, immersa oramai nella sua “vecchiezza”.
Per il resto rimane l’ineludibile fatto che “del diman non v’è certezza”.
Claudio Gliottone


 QUANTO È BELLA GIOVINEZZA
QUANTO È BELLA GIOVINEZZA  QUANTO È BELLA GIOVINEZZA
QUANTO È BELLA GIOVINEZZA  INCONTRO FORMATIVO SU COMUNICAZIONE EMOZIONALE E DISTURBI ALIMENTARI ALL’I.C. “VINCENZO LAURENZA” DI TEANO.
INCONTRO FORMATIVO SU COMUNICAZIONE EMOZIONALE E DISTURBI ALIMENTARI ALL’I.C. “VINCENZO LAURENZA” DI TEANO.  CONTINUA IL DRAMMA DEL NUOVO (VECCHIO) SCUOLABUS
CONTINUA IL DRAMMA DEL NUOVO (VECCHIO) SCUOLABUS  QUANDO L’ABITO…FA IL MONACO!!!
QUANDO L’ABITO…FA IL MONACO!!!