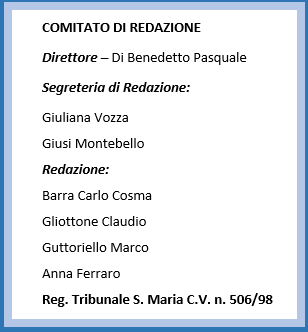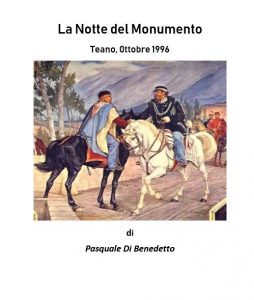Nel VI canto dell’“Eneide”, al verso 853, Virgilio pone, tra i tanti meriti che hanno consentito al popolo romano di dominare il mondo, quello di aver sempre saputo “parcere subiectis et debellare superboss”, cioè risparmiare gli arresi e sconfiggere i ribelli.
In questi termini la traduzione dal latino lascia intendere, per mettere in atto il precetto, un precedente scontro dal quale derivano coloro che si arrendono e quelli che invece continuano a combattere: e, stando così le cose, sarebbe difficile da parte nostra condannare d’emblée quelli identificati come ribelli.
Nei fatti la traduzione di “superboss” con ribelli è sicuramente edulcorata, laddove la “superbia”, riconosciuta dalla Chiesa come uno dei sette peccati capitali, significa ben altra cosa.
Stando al dizionario essa rappresenta la “esagerata stima di sé e dei proprî meriti (reali o presunti), che si manifesta esteriormente con un atteggiamento altezzoso sprezzante e con un ostentato senso di superiorità nei confronti degli altri”; pertanto i superbi: “ credono di meritare per sé stessi, con ogni mezzo, una posizione di privilegio sempre maggiore rispetto agli altri e questi devono riconoscere e dimostrare di accettare la loro inferiorità correlata alla superiorità indiscutibile e schiacciante del superbo “.
Quanti ne incontriamo ogni giorno! Quello che ti sorpassa pericolosamente, quello che ti strombazza dietro al semaforo, quello che ti scavalca nella fila all’ufficio postale, il professionista che ti fa aspettare per ore o l’impiegato che manco ti sta ad ascoltare, cosa sono se non piccoli esempi di superbia mascherata ed accoppiata a maleducazione?
Ma se ampliamo lo sguardo ci accorgiamo facilmente di quanto più danno provochi la superbia che si diffonde tra ceti sociali o gruppi di pensiero, diventando alla fine l’unico principale elemento di coesione tra i relativi componenti e rafforzando di conseguenza l’atteggiamento del gruppo.
Se questo accade nel “Circolo della stampa” o nel “Club degli scacchi” poco male: ne potrebbe conseguire solo un giudizio poco lusinghiero da parte dei non-soci.
Ma se questa superbia si impadronisce e si diffonde nei gruppi politici o di potere, od anche solo in qualcuno di loro, allora i pericoli sono ben maggiori perché verrebbero meno dei fondamentali ed indispensabili presupposti di democrazia e di libertà.
Così nascono aggregazioni ideologiche che si auto-alimentano sul presupposto per nulla provato della loro superiorità ideologica, perdendo il contatto con la Storia, la quale ne ha magari documentato la totale inconsistenza. Si rafforzano nella errata convinzione della inferiorità di chi non la pensa come loro e ne fanno oggetto di critica continua e gratuita, spesso mendace e non basata su dati di fatto. Non sfugge loro nessuna occasione per biasimare gli avversari con speciosi e banali argomenti, spesso ridicolizzando ad arte situazioni o loro dichiarazioni. In tutto questo non si fanno mai mancare la “demonizzazione” dell’avversario al quale rivolgono accuse di deviazioni democratiche o sociali inventate allo scopo, o, se tutto manca, vicinanze a periodi storici di cento anni fa. Ma cosa differenzia questa autoreferenziale superiorità, questa “intellighenzia” , dalle caste aristocratiche e nobiliari o borghesi combattute e vinte dalla Rivoluzione Francese prima e da quella Russa dopo, nei secoli scorsi?
Forse non mangia brioches di buon mattino, come Maria Antonietta di Francia, ma anni fa amava distinguersi negli abbigliamenti (il loden o l’eskimo, le scarpe Clark) nei ritrovi, nella musica d’avanguardia, nelle letture, nella partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche che invece avrebbero richiesto una presenza pacifica e democratica, senza le devianze chiassose che fanno automaticamente perdere di vista o sottovalutare la vera essenza della protesta.
E vivono sempre con un nemico da combattere, affibbiandogli spesso nefandezze che non stanno né in cielo né in terra.
È accaduto anche a ridosso delle ultime elezioni politiche, con il risultato del prevedibile “effetto boomerang” che ha travolto la sinistra.
Non vi pare che sia questa una verosimile interpretazione della accezione più importante del termine “superboss”?
Impareranno la lezione, questa volta? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Un dubbio mi assale: devo ascrivere questo pezzo alla rubrica “filosofica” o a quella di varia umanità?
Giudicate voi.
Claudio Gliottone


 DEBELLARE SUPERBOSS
DEBELLARE SUPERBOSS  DEBELLARE SUPERBOSS
DEBELLARE SUPERBOSS 
 VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO
VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO  LA SCOPA NUOVA…
LA SCOPA NUOVA…