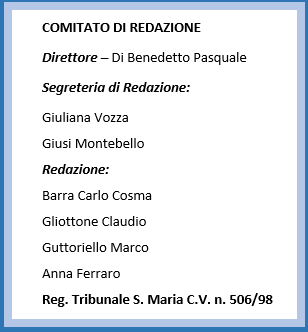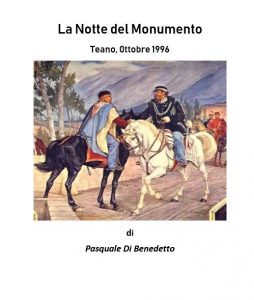Sicuramente non tutti i nostri lettori avranno l’abitudine di acquistare e leggere “quotidianamente” un quotidiano. Molti lo giudicheranno un mezzo di acquisizione di notizie ormai superato, vista la facilità e addirittura la contemporaneità con cui queste ci vengono fornite da uno straripante mondo di “media” (che, ricordo, è un termine latino e non inglese e va pronunciato come scritto).
Il fatto è che l’apprendere la “notizia” è diventato una necessità vitale, che ci accomuna e ci fa sentire alla altezza sociale di ogni conversazione, non esclusi dalla odierna globalità: e più particolari si conoscono di essa, più ci si sente superiori agli altri.
Poco importa se di quella notizia non si conoscono le motivazioni, magari lontanissime, che l’hanno prodotta, né il suo impatto sulla società, né le previsioni positive o negative ch’essa può comportare a seconda di più diversi punti di vista. Basta saperne più particolari possibili e fermarsi lì, alla “informazione”, fugace e spesso superficiale, che non diventerà mai “formazione”.
La lettura di un giornale o, meglio, di più giornali, va ben oltre, perché la notizia, scritta indelebilmente su carta e non affidata all’etereo etere, viene presentata già analizzata da esperti giornalisti, con i quali si può essere o non essere d’accordo, ma che comunque forniscono elementi di valutazione che allargano la visione dei fatti esposti inducendo il lettore a più approfondite considerazioni. È così che si maturano un personale spirito critico il meno possibile partigiano e la capacità di allargare orizzonti interpretativi indispensabili al vivere sociale pacifico e costruttivo.
Non meno importante è l’accesso alla pagina culturale, un tempo definita la “terza pagina”, di molti quotidiani, nella quale letterati, sociologi, umanisti, più che semplici “reporter”, offrono al lettore la conoscenza di più svariati argomenti volti ad affinare sensibilità e vastità mentale così importanti in un mondo sempre più moralmente arido.
Tra questi il già più volte citato scrittore Alessandro D’Avenia, illustre penna del “Corriere della Sera”, puntuale nei suoi editoriali del lunedì mattina.
Vi proporrò, stavolta, alcune sue profonde riflessioni su un tema del giorno, le vacanze, che, a suo parere, non dovrebbero rappresentare una “fuga da ciò che è ordinario, né presenza nello straordinario, ma apertura alla vita”.
La vacanza, dice, è una condizione, uno stato dell’animo; non un “posto”. Pertanto non è necessaria la ricerca di posti o situazioni “nuove”, perché nuovo, in questo caso, “non è sinonimo di più recente o più desiderato” perché questi sono concetti che possono essere presto superati o sostituiti. Il vero “nuovo – sostiene il Nostro – non invecchia e non è sostituibile, è sempre nuovo, anche nel “di nuovo”. Anche per questo in vacanza si torna sempre negli stessi posti, perché restano “nuovi”; e cita Omero, come più nuovo di qualsiasi giornale, o Beethoven, più nuovo di qualsiasi tormentone musicale estivo.
Il nuovo è qualcosa che ci rinnova perché denso di vita e ci offre quello di cui abbiamo bisogno per essere “vivi” e non solo “in vita”, prosegue D’Avenia: per farlo abbiamo bisogno di “meravigliarci”, perché “la meraviglia aumenta la vita spirituale, dove la vita ha senso di per sé e non per la sua utilità, come una mela di Cézanne, che non puoi mangiare ma solo amare”.
Solo questo potrebbe servire a lenire due tipi di disperazione: “non riuscire ad accettare sé stessi e non riuscire a diventare sé stessi”. La vacanza quindi non dovrebbe essere “ri-posare”, cioè porre di nuovo l’io dentro se stesso, ma “so-stare”, cioè so stare in me stesso!
Claudio Gliottone




 CONTINUA IL DRAMMA DEL NUOVO (VECCHIO) SCUOLABUS
CONTINUA IL DRAMMA DEL NUOVO (VECCHIO) SCUOLABUS  QUANDO L’ABITO…FA IL MONACO!!!
QUANDO L’ABITO…FA IL MONACO!!!  BUON NATALE
BUON NATALE