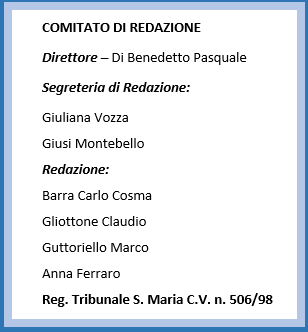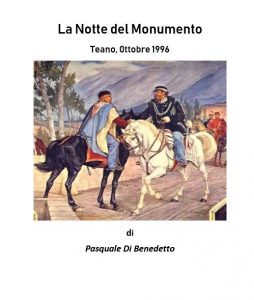ROMA (25 marzo) – Se il Risorgimento fosse stato un film, aveva scritto qualche anno fa Luciano Cafagna, avremmo avuto molti comprimari, pochi protagonisti ma sicuramente un solo grande regista, Camillo Benso, conte di Cavour. Invece, il drammatico e sanguinoso periodo storico che chiamiamo Risorgimento non fu un film, bensì una lunga e complessa scommessa politica che riuscì perché, dagli anni ‘50 al 1861, il gioco passò quasi sempre dalle abili mani di Cavour. Lo statista piemontese, infatti, grazie alla sua peculiare capacità di coniugare “fortuna” e “virtù”, era l’unico “giocatore” a poter contare su una passione progettuale guidata, però, da un freddo coraggio che, anche quando tutto sembrava sul punto di fallire, gli permetteva, talvolta bluffando, di “rilanciare” invece di indietreggiare.
Un obbiettivo non da poco se tiene conto del punto di partenza: un regno, quello sabaudo, che non spiccava certo per lungimiranza politica, potenza economica e militare, retto da un sovrano rozzo quanto furbo, per nulla sensibile alla “poesia” del costituzionalismo, ma pronto a sfruttarne eventuali vantaggi espansionistici. Non di rado Vittorio Emanuele mostrò insofferenza verso quel ministro che lo superava in tutto. Come Gladstone con la regina Vittoria, anche per Cavour la strada del successo doveva passare proprio attraverso la resistenza alle angherie del sovrano: dopo un suo rimprovero, Cavour non esitò a mandare “S.M. al diavolo” comunicandogli comunque che “qualunque ministro avrebbe dovuto dare a quest’ora le sue dimissioni. Ma io non sono un ministro qualunque, pertanto rimango”. Un quadro di rapporti personali ed istituzionali complicato, quindi, a cui si aggiungeva la sfida degli altri progetti unitari, a cominciare da quello mazziniano alle cui idee si era ispirato Garibaldi, dominus incontrastato della mobilitazione popolare. La tensione tra forze politiche contrastanti, pur se legate ad un grande obiettivo comune, fu resa anche più aspra dal contesto internazionale precario che si reggeva sulla contrapposizione culturale, prima ancora che diplomatica, tra Gran Bretagna e Impero asburgico. Un’ulteriore complicazione veniva poi annunciata dalla resistenza al progetto unitario da parte di quella Chiesa che aveva tradito nel 1848 le speranze del patriottismo neoguelfo. La saldezza delle convinzioni ideali, permise però allo statista di muoversi abilmente tra i meandri del quadro interno ed internazionale, sempre pronto da una parte a “prendere la fortuna per i capelli”, poiché “ogni piano, ogni progetto è inutile – tutto dipende da un accidente”, ma dall’altra a creare le condizioni perché le opportunità accadessero. L’arma vincente di Cavour fu la sua genuina capacità di cogliere lo spirito dei tempi, quello della forza della modernità liberale, trasformandolo in azione politica in grado di armonizzare tutti gli eccessi degli ideali e dei protagonisti intorno a lui. La sua pragmatica visione del “giusto mezzo” s’impose. Non fu però la vittoria della medietà, ma del lucido realismo di chi sapeva che “la più bella impresa dei tempi moderni”, come volle definire il processo di unificazione, imponeva cautela ma anche se non soprattutto la valorizzazione di tutte le grandi energie ideali in gioco. Fu, in fondo, questa consapevole capacità di far dialogare realismo e idealità, cinismo e passione, a fare di Cavour il più grande statista europeo del XIX secolo. [Il messaggero.it] |
© COPYRIGHT 2009/2020 - Registrato Presso il Tribunale di S. Maria C.V. n.506/98 Direttore responsabile: Pasquale Di Benedetto - E' vietata la riproduzione anche parziale

 di Fulvio Cammarano
di Fulvio Cammarano