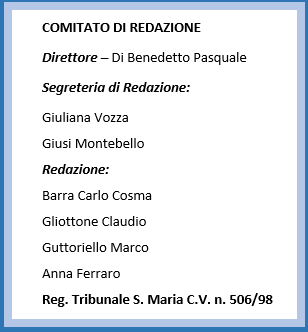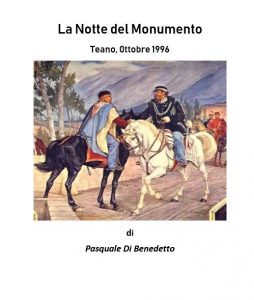Qualche lunedì fa ascoltavo una trasmissione giornalistica su Sky, per tema il famigerato art.18. Vi prendeva parte un giovane imprenditore calabrese, titolare di un’azienda con una ventina di dipendenti, tutti a tempo indeterminato, che produce particolari tipi di software. Coraggiosamente è rimasto in Calabria e gli affari gli vanno abbastanza bene. Non ha i problemi dell’art.18, cioè come licenziare dipendenti, ma l’esatto opposto, come trattenere dipendenti. I suoi problemi sono altri: anzitutto l’onnipresente burocrazia, e poi il digitai divide. Cioè la sua azienda non può operare in banda larga così come i suoi concorrenti settentrionali, ed una velocità appena sufficiente di trasmissione dati gli costa al mese quanto l’onere di due dipendenti, oneri che i suoi concorrenti non hanno.
Qualche lunedì fa ascoltavo una trasmissione giornalistica su Sky, per tema il famigerato art.18. Vi prendeva parte un giovane imprenditore calabrese, titolare di un’azienda con una ventina di dipendenti, tutti a tempo indeterminato, che produce particolari tipi di software. Coraggiosamente è rimasto in Calabria e gli affari gli vanno abbastanza bene. Non ha i problemi dell’art.18, cioè come licenziare dipendenti, ma l’esatto opposto, come trattenere dipendenti. I suoi problemi sono altri: anzitutto l’onnipresente burocrazia, e poi il digitai divide. Cioè la sua azienda non può operare in banda larga così come i suoi concorrenti settentrionali, ed una velocità appena sufficiente di trasmissione dati gli costa al mese quanto l’onere di due dipendenti, oneri che i suoi concorrenti non hanno.
Mesi fa ascoltavo una conferenza sulla presentazione di un libro, argomento la prigione di Fenestrelle e la scomparsa di circa 50.000 soldati dell’esercito delle Due Sicilie, tra cui, mi ha detto un amico, c’erano due teanesi. Uno dei relatori ad un certo punto disse che il Sud non doveva attendersi nulla da nessuno, che doveva rimboccarsi le maniche e darsi da fare, e che questa era l’unica strada percorribile per un certo progresso economico e sociale. Alla fine si aprì un dibattito con il pubblico. Un signore si alzò, si presentò: era un imprenditore del barese, non ricordo in quale campo. Spiegò che un suo collega trentino pagava alle banche un interesse del 4%; un suo collega lombardo pagava il 5%; lui pagava l’8% ed i colleghi calabresi pagavano il 10%, ammesso che trovassero banche che gli prestavano soldi. Disse che lui, per andare a trovare un cliente del nord, era costretto a cambiare tre treni per arrivare a Milano ed impiegava all’incirca sette ore di viaggio per cui era costretto a partire il giorno prima, cenare, dormire in albergo, svolgere le commissioni e se faceva in tempo, ripartire, altrimenti restare un’altra notte fuori, mentre il suo collega settentrionale in un’ora raggiungeva in treno tutte le destinazioni. Concluse dicendo che questa era la realtà delle imprese meridionali, che lui si era stufato di rimboccarsi le maniche, era una vita che lo faceva e che a furia di rimboccarsele, non aveva più le maniche.
Il giornale di un paio di domeniche fa aveva un articolo su Rocco Forte. Questo signore è figlio di Carmine Forte, nato in un piccolissimo paese della Ciociaria che io conosco per aver abitato a lungo lì vicino e che ogni tanto torno a visitare. Carmine raggiunse il padre in Scozia all’inizio del ‘900 e si industriò a vendere gelati per strada, sfuggendo ad una vita di fame e di stenti. Nella sua vita, partendo da zero, è riuscito a possedere fino a 800 (ottocento) alberghi e 1.200 ristoranti, con 70.000 dipendenti. Se fosse restato a Casalattico, il posto in cui nacque, probabilmente finiva a fare il pastore come tanti suoi compaesani.
Questi tre episodi spiccioli fanno intravvedere la realtà nella quale noi del Sud siamo costretti a vivere. La mancanza di infrastrutture e l’onerosità dei costi per i beni primari di una qualsivoglia attività imprenditoriale, dall’energia elettrica alle assicurazioni dei mezzi, rendono obiettivamente difficile competere con la concorrenza del nord ed ancora di più, estera. Certo, possiamo continuare a ripeterci che nel nostro DNA c’è il gene della sfaticataggine, che non ci diamo da fare aspettando l’aiuto statale seduti sul ciglio della porta, come non si stancano di ripetere quelli che dalla nostra sfaticataggine traggono profitto. Però allora non si comprende perché, appena varcato il Garigliano, questo gene scompare. Sarà l’aria? Sarà quel che mangiamo? Il governo attuale, tanto per risolvere il problema, ha tagliato drasticamente il cofinanziamento dei fondi europei a beneficio delle regioni settentrionali, che poverine ne hanno più bisogno. E la soluzione qual’è? Restare inerti a contemplare gli avvenimenti e imbeverci delle fesserie che ci ammanniscono ad ogni ora del giorno via etere?
Gino Gelsomino




 VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO
VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO  LA SCOPA NUOVA…
LA SCOPA NUOVA…