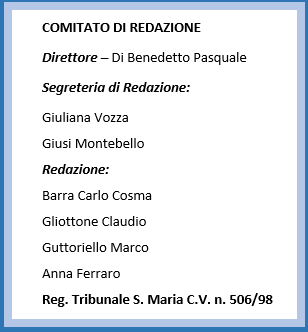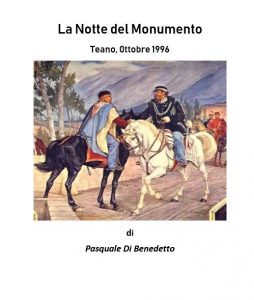Titolo in prima pagina a caratteri cubitali: “L’ira del vescovo si abbatte sulle fedeli della diocesi”; sottotitolo “il prelato si rivolge alle donne definendole bizzoche e le richiama all’ordine minacciando scomuniche”. Questo il tono di clamore che userebbe un attuale quotidiano locale ad una simile notizia, notizia che sembra uno scandalo, un’assurdità o frutto di fantasia: tutto vero invece, verissimo, ufficialmente documentato ed accaduto proprio a Teano, in quel Palazzo Vescovile accanto alla Cattedrale.
Ma il Vescovo non è certamente il buon Monsignor Arturo Aiello, amabile Pastore, che mai avrebbe minacciato di scomunica le proprie fedeli, né mai le avrebbe definite bizzoche, perché il sostantivo è offensivo, dispregiativo.
Insomma, tutto questo non è affatto assurdo, non è scandaloso e non vi è offesa alcuna nel termine associato alle donne; tantomeno si può dire che il Vescovo in questione sia stato un malvagio. Il paradosso è uno solo: l’evoluzione nel tempo, il miracolo della convivenza tra ciò che pian piano si trasforma sino a stravolgersi e ciò che sembra restare pressoché immutato nei secoli.
Questa che appare una curiosa vicenda è semplicemente il contenuto di un editto di Giuseppe Nicola Giberti, Vescovo della Santa Sede Apostolica di Teano nella seconda metà del 1600, il quale lamentava con rammarico l’inosservanza di alcune regole da parte di quelle donne della Diocesi che indossavano gli abiti della penitenza e che quindi corrispondevano alle bizzoche, ma senza che il termine all’epoca fosse offensivo, poiché indicava semplicemente quella categoria di donne più vicine alla Chiesa e che, un po’ come accade oggi, nell’ambito della comunità religiosa rappresentavano la parte più attiva e partecipe al culto quotidiano.
Lo stesso potente religioso, con tono imperioso e severo,con minaccia di scomunica imponeva l’osservanza di rigide e militaresche regole alle povere bizzoche, e quindi: l’obbligo di presentarsi alle autorità religiose per essere censite ed ottenere l’approvazione del proprio modo di vestire; il divieto di portare il velo e l’obbligo di indossare invece un panno che ricoprisse anche ogni lato del collo, il divieto di legare i capelli; l’obbligo di indossare abiti con maniche strette e con cinture non più larghe di un dito, di portare calze e scarpe rigorosamente scure; il divieto assoluto di soffermarsi dinanzi al confessionale oltre il tempo necessario alla confessione, di recarsi nelle chiese fuori orario per discutere tra di loro, quello di unirsi ad altre persone per orazioni nelle case proprie o altrui e finanche di prestare opere di bene come assistenza ai malati ed altro.
Il fatto narrato, riaffiorato casualmente sfogliando un antico libro e che non ha certo la pretesa di essere un rilievo storiografico, è una curiosità che colpisce non solo per il confronto con il presente ma anche perché sembra farci toccare con mano la storia.Una lontana realtà vista da vicino, in quanto propria di queste stesse mura in cui viviamo.
Tra l’altro ci presenta la Teano del passato, con la sua notevole influenza nel circondarioe quindi con un suo importante ruolo nell’evoluzione della gloriosa Terra di Lavoro.
Che dire poi della Chiesa del tempo? Istintivamente verrebbe certamente da criticarne i contenuti, perché il tono e la severità dell’editto sanno di vera ingiustizia.Ma la logica vuole che nella Chiesa del XVII secolo si riflette semplicemente il livello di civiltà di quell’epoca,nel bene e nel male, nella stessa misura in cui in quella attuale si riflette la società moderna.
Alla fine, alla luce dello stupore che può suscitare oggi il contenuto dell’editto, viene da chiedersi: chissà quale aspetto del nostro tempo apparirà più assurdo ed ingiusto ai posteri tra qualche secolo.
Gerardo Zarone